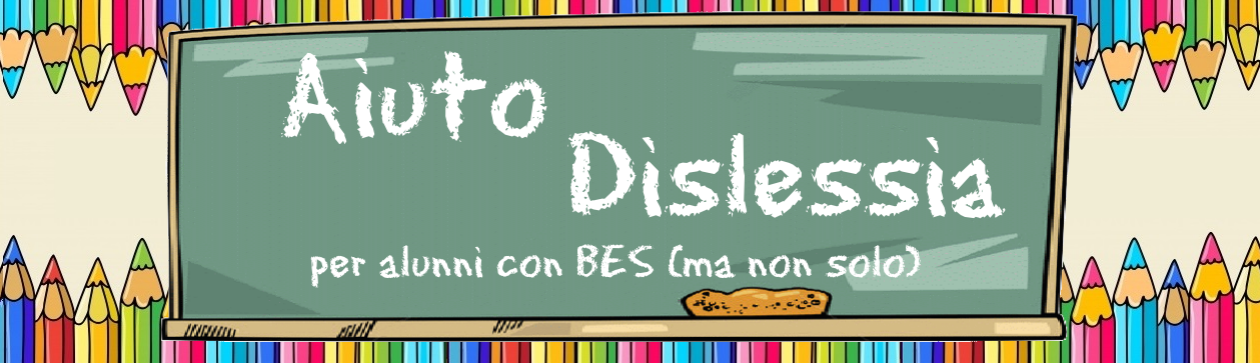Gli insegnanti di sostegno non sono dei super uomini e delle super donne, anche a loro capita di ammalarsi o di avere altri tipi di impedimenti che li costringono a stare lontani dalla scuola, quando questo avviene chi pensa allo studente con disabilità? Chi predispone attività da fare in classe o a casa?
Purtroppo in alcuni casi quando si presentano queste situazioni lo studente con disabilià viene lasciato a “sè stesso”, magari mandato in un altra classe dove è presente un altro insegnante di sostegno, in casi estremi viene chiesto alla famiglia di non mandarlo a scuola, cosa dice la normativa in merito?
C’è una voce del PEI che dovrebbe essere destinata proprio a chiarire questi aspetti:
Dicono le Linee Guida allegato B del DL 153/23, pag. 31:
«È necessario esplicitare in che modo viene utilizzata la risorsa del sostegno di classe e quali azioni sono previste da parte del team docenti in assenza di tale risorsa, coerentemente con quanto riportato nella Sezione 9 – Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse.»
E’ bene anche ricordare cosa dicono le Linee Guida sull’ integrazione scolastica per gli alunni con disabilità del 2009, pag. 18:
«… è l’intera comunità scolastica che deve essere coinvolta nel processo in questione e non solo una figura professionale specifica a cui demandare in modo esclusivo il compito dell’integrazione. Il limite maggiore di tale impostazione risiede nel fatto che nelle ore in cui non è presente il docente per le attività di sostegno esiste il concreto rischio che per l’alunno con disabilità non vi sia la necessaria tutela in ordine al diritto allo studio. La logica deve essere invece sistemica, ovvero quella secondo cui il docente in questione è “assegnato alla classe per le attività di sostegno”, nel senso che oltre a intervenire sulla base di una preparazione specifica nelle ore in classe collabora con l’insegnante curricolare e con il Consiglio di Classe affinché l’iter formativo dell’alunno possa continuare anche in sua assenza. »